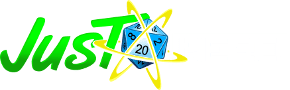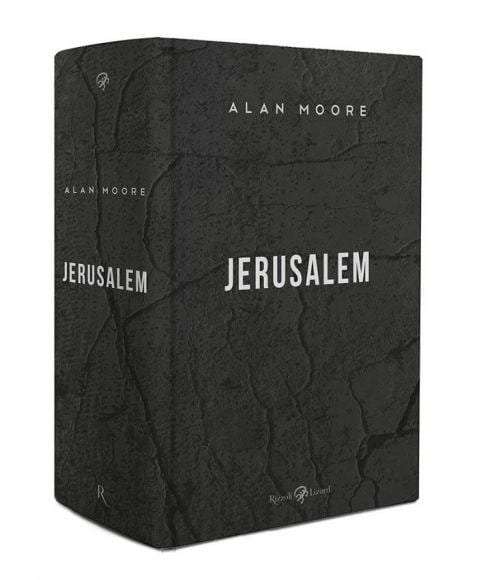È approdato da poco nelle librerie Jerusalem, il nuovo romanzo di Alan Moore edito in Italia da Rizzoli.
A dir la verità, definirlo “nuovo” è un po’ paradossale: il noto fumettista, famoso per lo più pervader creato Watchmen, V per Vendetta e From Hell, ci ha messo più di dieci anni per scriverlo!
Jerusalem, un mattone di 1500 pagine e più, è un romanzo che combina elementi storici e sovrannaturali. È suddiviso in tre Libri: Boroughs, Mansoul e L’inchiesta dei Vernall.
La trama s’inerpica attraverso i secoli, mostrandoci come Borough, il quartiere più antico di Northampton, si è trasformato nel corso del tempo. In particolar modo, ci mostra coloro che lo hanno popolato e cosa ci hanno lasciato in eredità.
I personaggi sono davvero tanti: alcuni sono leggendari o mitologici, molti sono fittizi, altri ancora sono storici (come Samuel Beckett, James Joyce, Albert Einstein). Le loro vite si intrecciano attraverso il tempo, spesso narrando gli stessi eventi con una chiave di interpretazione diversa.

Northampton protagonista
La vera protagonista di Jerusalem non è altro che la città natale di Moore, ovvero Northampton. Anzi, dopo qualche centinaio di pagine si inizia già a capire una verità incontestabile: Jerusalem è Northampton.
È noto che la città è stata un centro di eterodossia politica e religiosa. Per secoli i gruppi radicali (come i Livellatori o gli Antinomiani, per fare un esempio) hanno frequentato Northampton alla ricerca di una tana, di un posto dove ripartire da zero e creare la loro organizzazione ex novo. Insomma, cercavano un rifugio, una nuova Gerusalemme.
L’idea di base, d’altronde, è proprio quella dell’eternalismo, tanto caro a Moore: passato, presente e futuro coesistono nello stesso luogo, influenzandosi a vicenda.
Parola d’ordine: follia
Se la città è la protagonista del libro, l’elemento che fa da collante tra le varie storie narrate è sicuramente la follia.
Northampton sembra immedesimarsi nel ruolo della città santa così bene che ne incarna addirittura lo spirito e l’atmosfera. A volte si ha l’impressione di essere dentro una fiaba scolorita, dove facciamo fatica a riconoscerne i contorni e i colori. Tutto sembra sfuocato o visto attraverso uno specchio deformante.
In quasi tutti i capitoli, i personaggi hanno delle allucinazioni o delle visioni. A volte si tratta degli effetti collaterali dell’alcol o della droga, ma altrettanto spesso sono dovute a una fervida religiosità o a malattie mentali, come la schizofrenia.
Spesso la follia è accompagnata dall’elemento magico, com’era prevedibile. Moore è noto anche come occultista, tanto che si è autoproclamato mago. Durante la sua carriera ha anche proposto degli spettacoli teatrali che si sono rivelati poi dei veri e propri percorsi iniziatici, con tanto di riti magici. Era dunque inevitabile che non riversasse anche in Jerusalem la sua passione per l’occulto.
Lo stile
L’unica grande (anzi, enorme) pecca di questo romanzo sembra essere proprio lo stile.
Ho impiegato parecchio tempo per capire quale fosse l’idea di Moore riguardante la scrittura. Bisogna ammettere che si sforza di utilizzare una gamma variopinta di linguaggi diversi.
Ci sono dei capitoli che presentano uno stile molto basso, caratterizzato da una lingua simile a quella parlata o della strada, spesso anche volgare. Il lessico scelto è quello appartenente ai personaggi (anche loro di bassa estrazione sociale).
In altri capitoli, al contrario, lo stile diventa molto alto, preciso ed elegante. Esso viene dedicato perlopiù ai personaggi storici o a quelli riguardanti la sfera religiosa.
Devo ammettere che inizialmente ero convinta che Moore volesse descrivere le azioni dal punto di vista dei personaggi, addentrandosi nel loro modo di pensare.
Ma procedendo con la lettura mi sono resa conto che in realtà lo stile non rappresenta sempre la mentalità e la cultura dei personaggi. Al contrario, tende inevitabilmente verso un tono aulico, nonostante la presenza di parolacce e slang, come se l’autore si sforzasse di essere realista solo fino a un certo punto.
L’ostacolo di Jerusalem è proprio questo: un linguaggio troppo alto, prolisso, ripetitivo fino allo sfinimento e decisamente noioso.
Certo, i dettagli sono importantissimi in un romanzo, perché consentono al lettore di entrare nel vivo della narrazione e di assaporarne l’atmosfera, ma è altrettanto vero che i suddetti dettagli devono avere un loro perché: se gli oggetti descritti sono assolutamente comuni e non giocano un ruolo nel libro ma, al contrario, vengono dimenticati subito dopo la loro entrata in scena, gli sforzi dello scrittore diventano inutili.
Anche il lettore ne risente. Bombardato com’è di dettagli superflui e ripetizioni, rischia di incappare in quella che Walter Scott definiva “lodevole pratica del salto delle pagine”.
Ed è un vero peccato, perché i libri sono fatti per essere letti e assaporati, non per sfogliare i capitoli.
Conclusioni
Sicuramente Jerusalem è un’opera ambiziosa, anzi, forse è la più ambiziosa della carriera di Moore.
Per certi versi si tratta di un libro che sconvolge la letteratura contemporanea, impostando i capitoli con rigore e originalità.
Il modo in cui ci mostra la sua città natale è notevole: ci viene data la possibilità di vedere attraverso gli occhi di un bambino, poi di un vecchio, di una tossicodipendente e così via, ma anche di autori illustri e di schizofrenici.
Insomma, l’idea di base è degna di nota.
È un vero peccato che lo stile sia così soporifero: la voglia di leggere viene meno quando ci si ritrova davanti un volume grande come la Bibbia e con un linguaggio prolisso e ripetitivo.
Forse i dieci anni impiegati, tra revisioni e sostituzioni, non hanno giovato molto alla stesura finale di un’opera che comunque è il prodotto delle fatiche, degli studi e delle ambizioni di Moore.